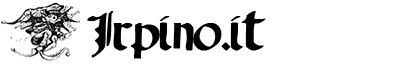Beni artistici e storici
-
Lo storico Palazzo Stiscia
Per gentile concessione di Giovanni Bosco Maria Cavalletti, Storia di Montecalvo Irpino, opera in allestimento.
 La famiglia Stiscia, attuale proprietaria dell’immobile che la tradizione orale tramanda come l’antica residenza di Mario Carafa, figlio di Giovan Francesco secondo conte di Montecalvo, riferisce che ancor prima dell’elezione episcopale di monsignor Gaetano Maria Stiscia a vescovo di Nusco (1860-1870), un loro avo l’acquistò dalla famiglia Volpe, di origine beneventana […][1]. Potremmo ipotizzare, secondo tale ricostruzione, che dagli eredi di Mario Carafa l’antico palazzo sia passato alla famiglia Volpe […] e, da questa, agli attuali proprietari Stiscia. Il palazzo originario fu raso al suolo e ricostruito ex novo dopo il terremoto del 21 agosto 1962.
La famiglia Stiscia, attuale proprietaria dell’immobile che la tradizione orale tramanda come l’antica residenza di Mario Carafa, figlio di Giovan Francesco secondo conte di Montecalvo, riferisce che ancor prima dell’elezione episcopale di monsignor Gaetano Maria Stiscia a vescovo di Nusco (1860-1870), un loro avo l’acquistò dalla famiglia Volpe, di origine beneventana […][1]. Potremmo ipotizzare, secondo tale ricostruzione, che dagli eredi di Mario Carafa l’antico palazzo sia passato alla famiglia Volpe […] e, da questa, agli attuali proprietari Stiscia. Il palazzo originario fu raso al suolo e ricostruito ex novo dopo il terremoto del 21 agosto 1962.
L’attuale residenza Stiscia
[1] La presenza a Montecalvo della famiglia Volpe è testimoniata dal certificato del 24 gennaio 1713 che attesta le pubblicazioni di matrimonio da celebrarsi tra la signora Giuseppa Piccirillo e il dottor fisico signor Luca Volpe di Benevento. Il cognome della futura sposa ci riannoda alla famiglia del rettore parroco di San Nicola, il reverendo Giuseppe Piccirillo che ebbe intensi rapporti con la città di Benevento essendo già dal 1695 il procuratore del canonico Paolo Farelli, arcidiacono della cattedrale beneventana, e dal 1706, per concessione dell’arcivescovo di Benevento il cardinale Vincenzo Maria Orsini, potette fregiarsi delle insegne canonicali della collegiata beneventana di Santo Spirito.
Redazione
[Crediti│Foto: Album di Famiglia] -
Piazza Purgatorio, oggi Piazza Vittoria
 Per gentile concessione di Giovanni Bosco Maria Cavalletti, Storia di Montecalvo Irpino, opera in allestimento.
Per gentile concessione di Giovanni Bosco Maria Cavalletti, Storia di Montecalvo Irpino, opera in allestimento.
All’inizio di Corso Vittorio Emanuele sorgeva il palazzo Caccese, uno dei più interessanti dal punto di vista architettonico. Esso faceva angolo tra il corso, ove affacciava l’ingresso principale, e la Piazza Purgatorio, oggi Piazza Vittoria. Era caratterizzato da una serie di cinque balconi sulla facciata principale e di due sul lato di Piazza Vittoria. Tutti della stessa grandezza si presentavano slanciati e sormontati ciascuno da armonici triangoli ornamentali scalpellati in pietra bianca. Privo di finestre su lato nord est, su cui insistevano due balconi armonizzanti con quelli del lato nord ovest, ne presentava otto sulla facciata principale, poste in doppia fila in corrispondenza dei quattro balconi, le superiori di doppia altezza rispetto alle omologhe sottostanti. Sotto il balcone centrale, ancora esistente, è collocato il magnifico portale in pietra bianca, vero capolavoro di sottili ricami. Su di esso campeggia lo stemma di famiglia. L’ala nord est del palazzo fu demolita dopo il terremoto del 1962; la parte estrema di quella nord ovest fu distrutta dopo qualche anno dal terremoto del 23 novembre 1980. Oltre al sontuoso portale ancora rimangono, del tutto, il balcone centrale ed uno laterale. Il palazzo Caccese a sud ovest, i Palazzi Franco a sud est e Capozzi a nord est, circondavano la vecchia piazza Purgatorio, così detta per la presenza della settecentesca chiesa del sacro cimitero intitolata a Gesù, Giuseppe e Maria, demolita a causa del sisma del 1930. Tutti e tre gli edifici furono letteralmente rasi al suolo dopo il terremoto del 1962. Sui loro siti sorsero delle moderne costruzioni che, irrispettose della storia e dell’arte, niente hanno conservato delle precedenti. La famiglia Franco era giunta a Montecalvo dopo la peste del 1656 inserendosi da subito tra le distinte famiglie locali. I Capozzi risiedevano a Montecalvo già nel XVI secolo, ma la loro residenza in Via Piano era stata costruita tra la fine del 1600 e l’inizio del 1700. In virtù di alleanze familiari il palazzo assunse il nome di Capozzi-Camerlengo-Caccese.Redazione

-
Il Palazzo Principe di via Costa dell’Angelo
Palazzo Principe (oggi Lazazzera) in completo abbandono. Si trova alla Costa dell’Angelo di Montecalvo, dove nacque, visse e ritornava d’estate con la famiglia l’avvocato Gustavo Console.
Redazione
[Bibliografia]
[M.Aucelli, Il fascismo a Montecalvo Irpino, Irpinia Libri, Monteforte Irpino AV, 2019]

-
La sèkoma: il tesoro nascosto della Valle del Miscano
Nel centro di Montecalvo Irpino il blocco di pietra di epoca ellenista racconta pratiche comunitarie ancestrali
Carmine Cicinelli
 [Edito 18/06/2023] Montecalvo Irpino, nella Valle del Miscano, è uno scrigno di bellezze e un crocevia di culture. Per visitarla in maniera approfondita non basta un giorno, e forse nemmeno una settimana, tante e tali sono le eccellenze sul piano naturalistico, culturale, storico e naturalmente gastronomico. Un tour per nella zona moderna, ricca di palazzi e chiese, una visita allo storico trappeto, un doveroso passaggio nell’antico borgo di Corsano, sono tutti percorsi turistici consigliati perché ognuno di questi luoghi racconta un pezzo di storia di un territorio davvero eccezionale.
[Edito 18/06/2023] Montecalvo Irpino, nella Valle del Miscano, è uno scrigno di bellezze e un crocevia di culture. Per visitarla in maniera approfondita non basta un giorno, e forse nemmeno una settimana, tante e tali sono le eccellenze sul piano naturalistico, culturale, storico e naturalmente gastronomico. Un tour per nella zona moderna, ricca di palazzi e chiese, una visita allo storico trappeto, un doveroso passaggio nell’antico borgo di Corsano, sono tutti percorsi turistici consigliati perché ognuno di questi luoghi racconta un pezzo di storia di un territorio davvero eccezionale.Per chiunque si avventuri a piedi per le stradine del centro del paese, magari per visitare la statua della Mamma bella dell’Abbondanza nella Cappella Carafa o per raggiungere il vicolo degli innamorati, con buona probabilità nei pressi della piazzetta che si apre su Corso Umberto I, dedicata alla vittima delle mafie Giovanbattista Tedesco, si imbatterà in questo singolare blocco di pietra.
A primo acchito può sembrare un reperto archeologico come tanti altri. Ma perché è in mezzo alla strada e soprattutto perché ha questa forma così complessa?
Per chi non la conoscesse si tratta della Sèkoma, un reperto raro e di grande fascinazione storica e dall’importante funzione. Si tratta infatti di uno strumento di precisione utilizzato in passato come pesa pubblica (probabilmente anche come contenitore per misurare la capacità dei liquidi). Una sorta di bilancia utilizzabile da tutti coloro ne avessero bisogno e, in casi estremi, utilizzata perfino dagli agoranomos (i responsabili delle agorà) per dirimere le controversie durante le compravendite.
Esteticamente si presenta come un parallelepipedo in pietra, di colore biancastro/grigio, di circa un metro e mezzo di lunghezza, all’interno del quale si trovano degli incavi semisferici di varie grandezze. Il più grande si trova proprio al centro e si chiama sekoma, ossia l’unità di misura di riferimento dell’epoca (siamo in epoca ellenistica, nel III-II secolo a.C.), che ha una capacità di 73 litri. Accanto ad essa, sui lati, ci sono le sekomata, incavi più piccoli rappresentanti dei sottomultipli. Piuttosto controversa la questione sulla principale funzione della sekoma di Montecalvo Irpino: se per lungo tempo si è pensato rappresentasse una pesa pubblica per i cereali, in particolare il grano considerata la lunga tradizione locale, la presenza di fori di scolo sottostanti gli incavi suggerisce che in origine venisse utilizzata per misurare i liquidi. Qualsiasi sia la tesi giusta, di certo è evidente per chiunque di trovarsi di fronte un pezzo di storia molto importante.
Non è possibile quantificare il valore intrinseco di questo oggetto, ma indubbiamente ci si può fare un’idea del valore simbolico e storico della sekoma di Montecalvo Irpino. Basti pensare che al mondo ne esistono solo altri 2 esemplari, e quella nel paesino del Miscano è l’unica di questa forma in tutta l’Europa Continentale.
A questo punto la domanda più scontata è: cosa ci fa a Montecalvo Irpino questo simbolo della cultura ellenista? Si sono fatte tante ipotesi, la più accreditata di queste ne attribuisce la presenza al transito dei Siracusani di Gerone, che, di passaggio in questo territorio per andare a sostenere Cuma nel 424 a.C., finirono per stanziarsi in zona, apportando logicamente i loro consueti usi e costumi. Un ipotesi per nulla peregrina, pensando alla suggestiva genesi dell’Ospedale di Santa Caterina, sempre a Montecalvo Irpino, fondato dai Cavalieri di Malta Gerosolimitani anch’essi di passaggio qui, di ritorno dalle crociate. [Nativo]
-
La statua di San Rocco in Santa Maria
La statua di San Rocco nella Chiesa di Santa Maria Assunta

DESCRIZIONE: Il Santo è rappresentato mentre, con lo sguardo rivolto al cielo, solleva l’abito con la mano destra al di sopra del ginocchio per mostrare il bubbone che compare sulla gamba; è accompagnato dal cane che stringe tra i denti un tozzo di pane
NOTIZIE STORICO CRITICHE: La statua risente degli influssi della cultura figurativa napoletana della prima metà del XVII secolo, caratterizzata da un marcato espressionismo e sentimentalismo di derivazione fiamminga e spagnola, uniti alla tradizione tardomanieristica italiana. E’ da sottolineare la particolare cura prestata dall’ignoto esecutore dell’opera, nel trattamento del panneggio e nella resa naturalistica dei gesti del SantoRedazione
[Crediti│Testo: Catalogo Beni Culturali│Foto: Catalogo Beni Culturali] -
Il fonte battesimale nella Chiesa di S. Maria Assunta

Descrizione: Sulla lastra anteriore della vasca, un semplice riquadro incornicia un’iscrizione riferita all’anno 1491; la vasca presenta resti di una policromia originale composta da una base giallo ocra, uniforme,
senza sfumature, e delle venature rosse.Notizie storico-critiche: La vasca originariamente poggiava su due capitelli di epoca più antica, provenienti, probabilmente, dall’antica chiesa di S. Angelo, soppressa nel 1693, ed oggi esposti nella Cappella Carafa. Il fonte battesimale era, inoltre, sormontato da una struttura lignea piaramidale e presenta segni di una policromia originale. La parte posteriore non è rifinita e ciò induce a ritenere che il manufatto fosse in origine concepito per altra funzione e addossato, quindi ad una muratura. Il primo battesimo a questo fonte fu amministrato la notte di Natale del 1491 ed il 30 settembre del 1710, con i nomi di Domenico, Michele, Giovan Battista, fu battezzato San Pompilio Maria Pirrotti, unico Santo dell’ordine degli Scolopi.
Redazione
[Crediti│Testo: Catalogo Beni Culturali│Foto: Catalogo Beni Culturali] -
Il Palazzo ZUPI
Redazione
 La famiglia Zupi ebbe, e tutt’ora ha, residenza nel palazzo sito in Via Costa dell’Angelo sul cui portale ancora campeggia l’antico stemma scalpellato su pietra bianca. La sua presenza in Montecalvo è già documentata dal 1500 e sin da allora i suoi membri erano attivamente inseriti con distinzione nel tessuto sociale. Annoverò vari personaggi di rilievo nella vita pubblica locale contraendo alleanze con le principali famiglie del paese.
La famiglia Zupi ebbe, e tutt’ora ha, residenza nel palazzo sito in Via Costa dell’Angelo sul cui portale ancora campeggia l’antico stemma scalpellato su pietra bianca. La sua presenza in Montecalvo è già documentata dal 1500 e sin da allora i suoi membri erano attivamente inseriti con distinzione nel tessuto sociale. Annoverò vari personaggi di rilievo nella vita pubblica locale contraendo alleanze con le principali famiglie del paese.Per gentile concessione di Giovanni Bosco Maria Cavalletti, Storia di Montecalvo Irpino, opera in allestimento.
-
Il Palazzo CHIANCONE
 Quasi dirimpettai, i palazzi Chiancone e Ciampone, […] chiudevano la Via Piano dalla quale, parallele l’una all’altra, continuavano la Via Casalonga, oggi Via Nicola Pappano, e la Via Sant’Antonio. La famiglia […] ebbe palazzo gentilizio ed innalzò proprio stemma. Del palazzo Chiancone rimane oggi solo il pianterreno con il monumentale portale recante le insegne familiari. Godette di ius patronato sugli altari di Santa Lucia e di Sant’Antonio Abate nella chiesa del Santissimo Corpo di Cristo ove, nel 1698, dal cardinale Vincenzo Maria Orsini, futuro Papa Benedetto XIII, ricevette il patronato anche sull’altare del Crocifisso, condiviso con la famiglia Dattoli.
Quasi dirimpettai, i palazzi Chiancone e Ciampone, […] chiudevano la Via Piano dalla quale, parallele l’una all’altra, continuavano la Via Casalonga, oggi Via Nicola Pappano, e la Via Sant’Antonio. La famiglia […] ebbe palazzo gentilizio ed innalzò proprio stemma. Del palazzo Chiancone rimane oggi solo il pianterreno con il monumentale portale recante le insegne familiari. Godette di ius patronato sugli altari di Santa Lucia e di Sant’Antonio Abate nella chiesa del Santissimo Corpo di Cristo ove, nel 1698, dal cardinale Vincenzo Maria Orsini, futuro Papa Benedetto XIII, ricevette il patronato anche sull’altare del Crocifisso, condiviso con la famiglia Dattoli.Per gentile concessione di Giovanni Bosco Maria Cavalletti, Storia di Montecalvo Irpino, opera in allestimento.
Redazione
-
Il palazzo Pizzillo
Il ramo atripaldese della famiglia Pizzillo acquistò la parte del palazzo Bozzuti già residenza del barone Battimelli, marito di Antonia Bozzuti, stabilendovi la sua residenza.
 […] Sullo storico palazzo, già Bozzuti-Battimelli, campeggia lo stemma in pietra bianca raffigurante un pozzo sostenuto da un leone con una stella ad otto punte in capo, e, nella campagna, un’ostrica, elemento già presente nello stemma Bozzuti.
[…] Sullo storico palazzo, già Bozzuti-Battimelli, campeggia lo stemma in pietra bianca raffigurante un pozzo sostenuto da un leone con una stella ad otto punte in capo, e, nella campagna, un’ostrica, elemento già presente nello stemma Bozzuti.
Il tutto è sormontato da una corona che, nonostante rotta nel suo apice, parrebbe essere baronale.
 Il leone, il pozzo, o in altre varianti la fonte zampillante, e la stella ad otto punte, sono gli elementi dello stemma Battimelli, mentre l’ostrica è emblematica di casa Bozzuti.
Il leone, il pozzo, o in altre varianti la fonte zampillante, e la stella ad otto punte, sono gli elementi dello stemma Battimelli, mentre l’ostrica è emblematica di casa Bozzuti.
Potrebbe trattarsi, quindi, dell’originaria rappresentazione araldico familiare Battimelli-Bozzuti che i Pizzillo avrebbero fatto propria in virtù della presenza del pozzo (piccolo pozzo Pozzillo, da cui Pizzillo) nella raffigurazione blasonica.Per gentile concessione di Giovanni Bosco Maria Cavalletti, Storia di Montecalvo Irpino, opera in allestimento.
Redazione
-
Palazzo De Santis
Il monumentale portale De Santis in Via Santa Maria – Secolo XVI – Il palazzo di famiglia è crollato a seguito di eventi sismici.

[…] La famiglia de Santis, di origine spagnola, si stabilì nel Regno di Napoli nel XVI secolo.
Bartolomeo de Santis, con bolla di Papa Pio IV dell’11 febbraio 1562, divenne arciprete della chiesa abbaziale di San Nicola di Bari in Corsano. Nel 1573 era abate della stessa chiesa.
Prospero, figlio di Gaetano e di Rosa Antonini dei baroni di San Biagio, originario del Vallo di Diano (SA), sposato con la signora Diana di Natale dei baroni di San Mauro, dottore in utroque nel 1701, fu celebre medico del collegio di Salerno.
Girolamo, figlio di Prospero e di Diana di Natale, sposato con la signora Rachele Mezzanelli, dottore in utroque nella seconda metà del Milleseicento fu agente generale e viceduca di Montecalvo […]Per gentile concessione di Giovanni Bosco Maria Cavalletti, Storia di Montecalvo Irpino, opera in allestimento.
Redazione