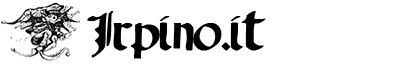Trekking
-
Il Trekking Pompiliano
 [Edito 09/07/2013] Lunedì, 15 luglio 2013, anniversario della divisione al cielo di San Pompilio Maria Pirrotti, si riproporrà un evento che negli ultimi anni ha visto la partecipazione di molti pellegrini e amanti del Santo: “Il Trekking Pompiliano” curato, come sempre, dall’infaticabile Gaetano Caccese. La partenza sarà effettuata da piazza S.Pompilio e da qui si avventureranno nell’antico percorso che il giovane Pirrotti compiva nel raggiungere la “Chiesa dell’Abbondanza” a lui tanto cara. Si attraverserà via lungara fossi, l’occhiu di lu diavulu, contrada conca, la zona della chiaria un vecchio percorso che anticamente si faceva a piedi per raggiungere il paese. Attraversando i calanchi della chiaria-conca ci si immerge in luoghi suggestivi e particolari, un paesaggio unico e suggestivo con molte particolarità naturali e alberi secolari. Durante il cammino oltre alla possibilità di incontrare aspetti faunistici interessanti si raccoglie la sensazione di un’immersione nella giungla , in quanto gli alberi maestosi e secolari che infoltiscono i luoghi con delle sensazioni uniche agli occhi del pellegrino, trasformando la fatica del cammino in un crescente arricchimento della conoscenza di luoghi splendidi che mai nessuno poteva pensare di aver a portata di mano, ma che spesso si pensa di girare il mondo per vedere.
[Edito 09/07/2013] Lunedì, 15 luglio 2013, anniversario della divisione al cielo di San Pompilio Maria Pirrotti, si riproporrà un evento che negli ultimi anni ha visto la partecipazione di molti pellegrini e amanti del Santo: “Il Trekking Pompiliano” curato, come sempre, dall’infaticabile Gaetano Caccese. La partenza sarà effettuata da piazza S.Pompilio e da qui si avventureranno nell’antico percorso che il giovane Pirrotti compiva nel raggiungere la “Chiesa dell’Abbondanza” a lui tanto cara. Si attraverserà via lungara fossi, l’occhiu di lu diavulu, contrada conca, la zona della chiaria un vecchio percorso che anticamente si faceva a piedi per raggiungere il paese. Attraversando i calanchi della chiaria-conca ci si immerge in luoghi suggestivi e particolari, un paesaggio unico e suggestivo con molte particolarità naturali e alberi secolari. Durante il cammino oltre alla possibilità di incontrare aspetti faunistici interessanti si raccoglie la sensazione di un’immersione nella giungla , in quanto gli alberi maestosi e secolari che infoltiscono i luoghi con delle sensazioni uniche agli occhi del pellegrino, trasformando la fatica del cammino in un crescente arricchimento della conoscenza di luoghi splendidi che mai nessuno poteva pensare di aver a portata di mano, ma che spesso si pensa di girare il mondo per vedere.La zona essendo quasi tutta selvaggia rappresenta una riserva naturale d’uccelli e animali di vario tipo , tassi ,volpi, cinghiali ecc . inoltre si nota lo svolazzare continuo di farfalle di ogni genere quasi come se ti trovassi in una riserva naturale, le pupille degli occhi battono come una macchinetta fotografica nel cercare di immagazzinare le immagini quasi in esclusiva del panorama e del paesaggio percorso. Si consiglia scarponi pantaloni, camicia , un bastone e una macchina fotografica.lungo il percorso si puo’ ammirare e scoprire qualcosa che mai nessuno spazio di ricerca , la stratificazione fossile di era glaciale compattata nei diversi livelli di sabbia e gliaia marina e delle cose piu’ interessanti del nostro è quella zona fino alla chiaria abbondanza di presenze e di possibilta’ visive. . A mio parere, Montecalvo tra straordinarie bellezze riserva dei percorsi di trekking unici, tutti da esplorare e opportunità di sviluppo turistico tutte da sfruttare, e grazie all’impegno dell’amico Gaetano Caccese che tutto si sta evidenziando grazie alla sua perseveranza. e grazie a tutti coloro che collaborano con lui. E dopo tanto camminare il ritorno in piazza S.Pompilio. [Nativo]
Nicola Serafino
-
IL TRATTURO DELLA TRANSUMANZA PESCASSEROLI – CANDELA
Mario Sorrentino
 [Edito 00/00/0000] Il tratturo ai tempi del Sannio antico, oltre che una reale via d’erba che potevano percorrere gli animali, valeva come simbolo dell’unione prima di tutto sacrale e poi culturale e politica delle diverse tribù dello stesso ceppo etnico che si erano andate diversificando nel tempo e nello spazio nelle due culture materiali dei pastori e degli agricoltori.
[Edito 00/00/0000] Il tratturo ai tempi del Sannio antico, oltre che una reale via d’erba che potevano percorrere gli animali, valeva come simbolo dell’unione prima di tutto sacrale e poi culturale e politica delle diverse tribù dello stesso ceppo etnico che si erano andate diversificando nel tempo e nello spazio nelle due culture materiali dei pastori e degli agricoltori.
Era la loro un’economia complementare che permetteva la reciproca sopravvivenza di allevatori e coltivatori in un territorio in prevalenza montuoso, aspro e molto freddo d’inverno, e con scarsi pianori coltivabili non molto fertili. Fondamento essenziale di quest’economia primitiva era perciò l’allevamento che avveniva con lo spostamento alternato in primavera e in autunno di milioni di capi di bestiame (pecore e capre, in prevalenza, ma anche buoi, maiali e cavalli) dai monti alle pianure, e viceversa, attraverso il vasto territorio compreso tra l’attuale Abruzzo e il Tavoliere pugliese.
I tratturi erano vie d’erba su terreni non fangosi aperti molto probabilmente dagli stessi animali che a branchi si spostavano alla ricerca dei pascoli, quando l’uomo del Neolitico si limitava a seguirli per cacciarli. Poi, con il susseguirsi delle varie civiltà (quella appenninica, i Sanniti, i Romani, ecc.) nel territorio attraversato dai maggiori tracciati, la transumanza fu organizzata e sfruttata economicamente, come è avvenuto sino a circa metà del secolo appena trascorso. “Sergenti” al comando dei pastori erano quei grandi e lanosi cani bianchi, selezionati anticamente e utilizzati ancora oggi per guidare le greggi: i cani di razza abruzzese.
Lungo il tratturo sorgevano le stazioni di sosta per il riposo di animali e uomini e per lo scambio di prodotti con gli agricoltori (lana, pelli, carne, formaggi, cuccioli contro cereali, olio e vino, e, su un piano solo per noi più elevato: lo scambio matrimoniale). Si svolgevano in quella occasione anche le varie ritualità ordinarie di tipo religioso (v. scheda su “Le Bolle della Malvizza”), politico e civile che cementavano la federazione delle diverse tribù sannite in tempo di pace. In guerra scattavano altri appuntamenti e riti propiziatori. Le stazioni di sosta erano quasi sempre comprese all’interno degli “oppida”. Piccoli centri urbani caratterizzati da un reticolo di vicoli contorti e stretti per poter controllare il deflusso delle greggi, dalla presenza di sorgenti abbondanti d’acqua, e difese da cinte di mura dette “ciclopiche” (mura di grosse pietre poste in opera a secco), le quali, dove possibile, venivano addossate a rocce, se non erano sostituite magari a tratti da queste quando erano inaccessibili naturalmente a nemici o a gruppi di predatori.
Gli “oppida” (sempre visibili tra loro almeno due a due) scandivano il tratturo in giornate di marcia in base alle esigenze del multiforme mondo di animali e uomini che si spostava due volte all’anno su e giù lungo il percorso, secondo il noto alternarsi “primavera – autunno” e “monte – piano”. -
LA STAZIONE DELLE PECORE DI TRE FONTANE
Mario Sorrentino
 In altre schede di questo sito parliamo della transumanza e dei tratturi (v. Le Bolle della Malvizza con la scheda storica e Monte Chiodo di Buonalbergo). Però pochi punti degli antichi tracciati danno come fa la stazione del tratturo di Tre Fontane l’impressione vividissima che essa sia stata appena occupata e svuotata nel perenne alternarsi della discesa delle greggi dagli Abruzzi e la loro risalita dalle Puglie lungo il Regio Tratturo.
In altre schede di questo sito parliamo della transumanza e dei tratturi (v. Le Bolle della Malvizza con la scheda storica e Monte Chiodo di Buonalbergo). Però pochi punti degli antichi tracciati danno come fa la stazione del tratturo di Tre Fontane l’impressione vividissima che essa sia stata appena occupata e svuotata nel perenne alternarsi della discesa delle greggi dagli Abruzzi e la loro risalita dalle Puglie lungo il Regio Tratturo.
Sorge questa stazione tra la valle del torrente Cervaro e quella del torrente Miscano, nelle acque del quale venivano lavate le pecore prima della tosatura all’altezza del Ponte Bagnaturo, così chiamato proprio per questo uso.
Tre Fontane è precisamente una sezione tagliata nella Via Traiana, che i romani costruirono del resto anche su uno dei tratturelli preesistenti e diramantisi dal ramo principale e preistorico di quello che sarà chiamato Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, quando venne istituita la Dogana di Foggia con un decreto di Alfonso d’Aragona, nel 1447. Abbandonata la via romana alla decadenza, i pastori si ripresero i tratturi, fra i quali questo che passava da Tre Fontane.
Ancora abitata oggi, la stazione si trasformò per ultimo in masseria, ma ha preservato tra le altre antiche strutture due grandi e lunghi abbeveratoi alimentati dalle sorgenti che, c’è da credere, sempre li hanno riempiti e li riempiono di fresca e abbondante acqua. Alla stazione delle pecore si entrava e si usciva da due ampie porte ad arco a tutto sesto che si fronteggiavano e si fronteggiano nel senso ovest/est. Lungo il lato opposto al muro di cinta in grossi blocchi di pietra, che corre in questo stesso senso, ci sono ancora gli edifici antichi anch’essi in pietra e ancora quasi integri, i quali sono prolungati dalle costruzione recenti della masseria.
Se si sta in piedi al centro della corte principale, con i piedi immersi nell’erba folta, e si chiudono gli occhi, facilmente l’immaginazione suggerisce i belati e i forti afrori degli animali, le urla rauche dei pastori e l’abbaiare dei grossi cani abruzzesi.
Andiamo a visitare il cortile più piccolo verso nord, passando sotto un portico ad arco che sorregge ancora l’abitazione dei “signori”, come li chiama il figlio della proprietaria della masseria. Soggiornavano lassù una volta i padroni delle greggi che le seguivano a cavallo, e dopo, in tempi più recenti, i proprietari della masseria. In questa corte piccola c’è ancora la stalla riservata alle bestie “partorienti” e ai nuovi nati destinati a rimanere indietro rispetto al grosso che ripartiva. La stalla ha dei compartimenti delimitati da muretti di pietra per la “comodità” delle singole madri e dei loro piccoli.
Prima di partire beviamo ancora dai getti degli abbeveratoi l’acqua gelata; e ci sembra di compiere un rito che se ancora ristora non ha per noi l’importanza vitale, quasi sacra, che aveva per quei pastori.Francesco Cardinale ed io (Mario Sorrentino) ringraziamo Gaetano Caccese che ci ha fatto scoprire Tre Fontane guidandoci sin lì.
-
Il Trekking Pompiliano dell’infaticabile Gaetano Caccese

Gaetano Caccese, presso la fontana dell Abbondanza Montecalvo Irpino AV – Domani, 29 settembre, è l’anniversario della nascita di San Pompilio. Come ogni anno, in occasione di questa ricorrenza, ci sarà un’escursione lungo i luoghi percorsi dal Santo che partirà alle ore 8:00. L’appuntamento è davanti alla chiesa.
È ammirevole il lavoro, la costanza e la perseveranza che l’infaticabile Gaetano Caccese mette nell’organizzare questo percorso a piedi da oltre venti anni. Il cammino collega la chiesa di San Pompilio di Montecalvo ai ruderi della chiesa dell’Abbondanza, situata nella contrada Mauriello, che dista almeno quattro chilometri dal paese.
Il trekking Pompiliano è il nome dato a questo cammino, che segue il percorso che il Santo faceva quando si dirigeva verso la chiesa situata nelle terre di sua proprietà. È un itinerario suggestivo e affascinante che si snoda lungo la “Ripa della Conca”. Appena dopo aver superato l’antico ospedale di S. Caterina, ci si imbatte nella Grotta dei Briganti e in alcuni casolari abbandonati. Arrivati in fondo, dopo aver quasi toccato i calanchi con mano, si attraversa un ponticello costruito da Caccese stesso, che serve per oltrepassare un ruscello. Qui si può osservare, sulla cima di un costone dalla quale fuoriesce acqua ferruginosa di colore rossastro, una cavità chiamata “l’Occhio del Diavolo”, ed è altresì possibile notare fusti di alberi secolari così alti che la vista verso l’alto si perde tra le loro cime.
Dopo aver attraversato l’area boschiva che costeggia la “macchia Cavalletti”, ci si inoltra lungo un crinale di arenaria, un’altra meraviglia per chi ama scoprire luoghi incontaminati. Ricordate una pubblicazione uscita qualche tempo fa, realizzata dall’Istituto Comprensivo di Montecalvo Irpino, intitolata “C’era una volta il mare…”? Infatti, qui è possibile toccare con mano i reperti descritti in quel volumetto, come i resti di fossili di conchiglie di ogni ordine e grandezza.
Infine, si giunge ai ruderi della chiesa e della fontana dell’Abbondanza. Alcuni anni fa, il vulcanico Gaetano Caccese riuscì persino a coinvolgere Don Teodoro Rapuano, l’ex parroco di Montecalvo, guidandolo lungo i tortuosi pendii del percorso. Il reverendo, dopo aver tenuto compagnia ai partecipanti durante il tragitto, celebrò messa proprio lì, tra i resti di quello che un tempo doveva essere un luogo di culto molto sentito sia per San Pompilio che per i fedeli delle contrade vicine.
[Correlato│L'Occhio del Diavolo][Bibliografia di riferimento]
[Di Giovanni E. – Favorito A., C’era una volta il mare, Arti Grafiche Tommasiello, Montecalvo Irpino AV, 2002]Francesco Cardinale